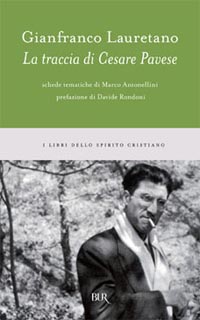Viaggio nei luoghi e nelle parole dello scrittore
Introduzione
Si viaggia da soli?
Pavese lo sapeva bene, un viaggio non si fa da soli. Per un mucchio di motivi: perché è triste; perché la complessità del mondo soverchia la capacità di vedere di due occhi soltanto; per parlare con qualcuno; perché parlando con qualcuno le cose non corrono più alla solita velocità. Ma per Pavese ci sono almeno due motivi ancora più penetranti per non giustificare la solitudine del viaggio. Il primo è che tutto l’essere fin nelle sue radici grida contro la solitudine, per cui la solitudine stessa è annuncio di un altro, sotto le cui “ali” bisogna stare. Lo dice in una pagina del Mestiere di vivere, il diario che lasciò come eredità e che è una delle più belle e vaste raccolte di pensieri della nostra letteratura: così come il Mestiere rinnova il diario esistenziale e letterario dopo lo Zibaldone di Leopardi, così i Dialoghi con Leucò (una copia del quale fu trovata nello stesso luogo e nello stesso momento) ripropongono le Operette morali del poeta di Recanati. Leopardi e Pavese, dunque. Ma ascoltiamo la pagina del diario del 12 aprile ’47:
Tu sei solo, e lo sai. Tu sei nato per vivere sotto le ali di un altro, sorretto e giustificato da un altro, che sia però tanto gentile da lasciarti fare il matto e illudere di bastare da solo a rifare il mondo. Non trovi mai nessuno che duri tanto; di qui, il tuo soffrire i distacchi – non per tenerezza. Di qui, il tuo rancore per chi se n’è andato; di qui la tua facilità a trovarti un nuovo patrono – non per cordialità. Sei una donna, e come donna sei caparbio. Ma non basti da solo e lo sai.
“Non basti da solo e lo sai”. Sì, Pavese lo sapeva bene, e ne ha parlato così tanto da passare per lo scrittore della solitudine. Ma tutta la sua opera afferma il contrario, fugge da questa tristezza e lotta contro questa apparente evidenza della solitudine contro cui deve aver lottato tutta la vita, arrendendosi solo alla fine. È chiarissimo quasi ad ogni respiro della sua opera che cercare la verità del proprio viaggio e del proprio destino significa riconoscere che esso non si fa da soli.
Nello stesso tempo tante volte deve aver sentito la puntura dello scivolamento nella solitudine come quando, spinto da quel pungolo, aveva attraversato camminando strade e piazze deserte; e deve essersi imbattuto più e più volte in quel diaframma di estraneità che sembra tenerci tutti, ultimamente, lontani. Se l’essere insieme, la compagnia è qualcosa che compie la vita, Pavese ne è il poeta, rimanendo insieme il cantore della incapacità sua e nostra di realizzare compiutamente quella comunione tanto anelata. La sua scrittura in certi scatti della poesia o nell’essere brusca nei dialoghi e nei personaggi (anche in questo piemontese, come l’altro suo grandissimo conterraneo, Beppe Fenoglio) sa diventare drammatica e mossa; ma sa anche distendersi con respiro e dettagliata precisione nella descrizione dei luoghi e nel resoconto degli stati d’animo; in tutti i casi ciò che la muove e le consente di scendere nell’interiorità recondita dell’anima e dei sentimenti è questa lotta tra ineluttabilità e rifiuto della solitudine, proprio come accade a Stefano, protagonista de Il carcere:
La solitudine sarcastica cedeva. E se cedeva in quella sera piena di tanti fatti nuovi e improvvisi ricordi, come avrebbe potuto resistere l’indomani? Senza lotta, s’accorse Stefano, non si può stare soli; ma stare soli vuol dire non voler più lottare (cap.VII).
Nell’essere non siamo soli, questo insegna Cesare Pavese. E questo è il vero motivo che mi ha spinto a questo viaggio. Una ragione all’inizio solo intuita, vagamente, trattenuta dal ricordo di una lettura lontana delle sue opere, compiuta ai tempi dell’università e prima ancora, poi via via più chiara, persino letteraria: non si viaggia da soli, non si scrive da soli (paradossale no?). Non si vive da soli. Tutto il nostro essere grida, con Pavese, la domanda di un rapporto.